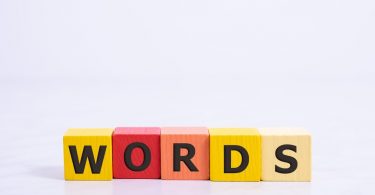Avevo diciassette anni quando ho detto a mio padre di essere omosessuale. L’ho fatto senza retorica, senza aspettarmi applausi, ma con un nodo alla gola. Avevo passato mesi a trovare il coraggio per dirlo. Pensavo che la verità, una volta detta, mi avrebbe alleggerito. Invece, ha scatenato una tempesta. La sua reazione è stata glaciale. Mi fissava come se non mi riconoscesse più, come se all’improvviso fossi diventato un estraneo. Dopo qualche giorno di silenzio assoluto, mi disse che un prete “illuminato” mi avrebbe aiutato a “ritrovare la mia strada”. Non usò mai le parole “terapia riparativa”, ma quello era: un tentativo di “curare” qualcosa che non era una malattia.

Due volte a settimana, per mesi, sono stato costretto a sedermi davanti a un uomo in abito talare che mi faceva domande intime, invadenti, dolorose. Mi chiedeva se pensavo mai a una ragazza, se avevo “fantasie sane”, se avessi subito traumi da piccolo. Cercava un colpevole, un innesco, una causa. Come se amare qualcuno del mio stesso genere fosse una ferita da diagnosticare, non una parte legittima di me.
La cosa più assurda? In tutto quel tempo nessuno mi ha mai chiesto come mi sentissi. Nessuno si è fermato a guardarmi negli occhi e a dirmi: “Va bene così. Sei abbastanza. Sei amato.”
Le terapie riparative oggi sono vietate
Oggi, per fortuna, le cose stanno cambiando. In Italia, sebbene non ci sia ancora una legge nazionale ad hoc, nel 2020 l’Ordine degli Psicologi ha ribadito con forza che qualunque tentativo di “curare” l’omosessualità è non solo privo di valore scientifico, ma dannoso e contrario alla deontologia. A livello internazionale, le Nazioni Unite e l’OMS condannano da tempo queste pratiche come violazioni dei diritti umani.
Molti Paesi, come Germania, Francia e Spagna, hanno già messo al bando le terapie riparative. In Italia, varie regioni si sono mosse per vietarle a livello locale. Ma la strada è ancora lunga. Troppe famiglie, ancora oggi, credono che si possa “aggiustare” un figlio queer come si aggiusta un rubinetto che perde.
La solitudine dell’essere respinto da chi dovrebbe proteggerti
Essere costretto a nascondere chi sei è già un fardello. Ma sapere che tuo padre — colui che dovrebbe difenderti dal mondo — è il primo a voltarti le spalle, è una frattura che non si rimargina facilmente. La mia adolescenza è stata un deserto emotivo. Ogni parola detta era un rischio. Ogni silenzio, una condanna.
La cosa peggiore non era la “cura” in sé, il tentativo di terapia ripartiva in sé. Era la solitudine. Il sapere che non avrei mai potuto portare a casa chi amavo. Che ogni mio gesto sarebbe stato osservato, giudicato, corretto. A casa mia, l’amore era un errore da censurare.
Oggi sono lontano. E sono felice.
Non è stato facile, ma ho fatto una scelta drastica: me ne sono andato. Ho tagliato i ponti con la mia famiglia quando ho capito che continuare a restare avrebbe significato rinunciare a me stesso. E no, non è egoismo: è sopravvivenza.
Oggi vivo in un’altra città. Ho un lavoro che amo, amici che mi vedono per quello che sono, e un compagno che mi tiene la mano per strada senza paura. Ho scelto la felicità, anche se è costata cara. Anche se il prezzo è stato l’assenza di chi avrebbe dovuto amarmi incondizionatamente.
A chi vive una situazione simile, voglio dire questo:
Non sei sbagliato. Non devi essere aggiustato. L’amore non ha bisogno di giustificazioni. Se la tua famiglia non riesce a vederti, crea la tua. A volte, la libertà arriva solo quando si ha il coraggio di lasciare. E se il cammino ti sembra troppo duro, ricorda: esistono comunità pronte ad accoglierti. E sei già intero, così come sei.