In una società che premia l’efficienza, la performance, la velocità, fermarsi ad ascoltare le emozioni è spesso un atto rivoluzionario. Ma se lo è per le persone adulte, cosa succede quando ci troviamo a immaginare che tutto questo riguardi anche le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi? Cosa significa alfabetizzazione emotiva? L’alfabetizzazione emotiva è una pratica culturale prima ancora che psicologica. È il fondamento non detto di una società che sceglie se crescere individui consapevoli o contenitori svuotati, capaci di sopravvivere ma non di vivere davvero.
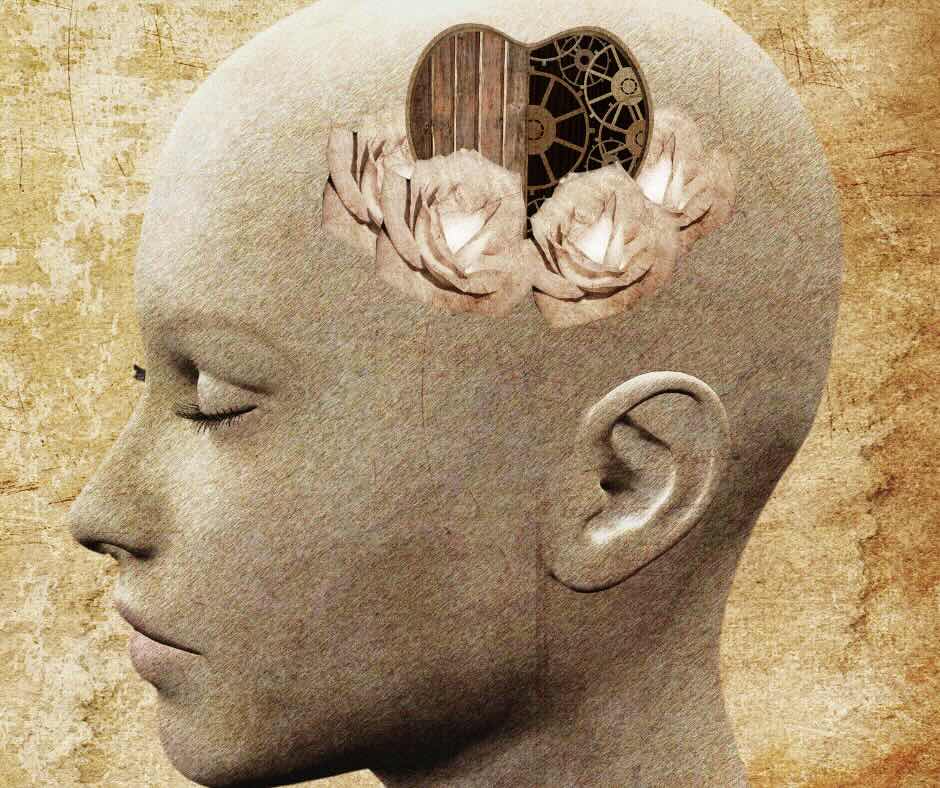
L’arte di dare un nome a ciò che si prova
Il termine “alfabetizzazione emotiva” indica la capacità di riconoscere, comprendere, nominare e comunicare le proprie emozioni. Ma non si tratta soltanto di una competenza da inserire nei programmi scolastici. Insegnare alle persone, fin da piccole, a nominare ciò che provano significa legittimarle. Significa dire: “quello che senti conta”, in un mondo in cui invece spesso le emozioni vengono sminuite, ignorate, punite.
Non stupisce che le culture che maggiormente reprimono le emozioni siano anche quelle dove si registrano più alti tassi di disagio psicologico, violenza domestica, bullismo e solitudine. Non è un caso: la negazione delle emozioni è terreno fertile per l’oppressione.
Il contesto fa la differenza
Nel nostro Paese parlare di emozioni in modo aperto e autentico è ancora un tabù in molte famiglie e scuole. Il retaggio patriarcale, l’educazione cattolica rigidamente binaria, il timore di “indebolire” chi piange o ha paura, costruiscono un ambiente culturale in cui l’alfabetizzazione emotiva è vista come un lusso, un vezzo da pedagogiste o da genitori “moderni”.
Eppure, una cultura che non conosce e non riconosce le emozioni è una cultura che prepara il terreno alla violenza, all’incomprensione, al disagio sommerso. Un corpo che non può piangere è un corpo che imploderà in altri modi: con ansia, rabbia esplosiva, disturbi depressivi, e così via.
Alfabetizzazione emotiva e giustizia sociale
Parlare di emozioni è anche un atto di giustizia. Le bambine e i bambini cresciuti in contesti familiari oppressivi, violenti, silenzianti, non hanno solo bisogno di sicurezza fisica, ma anche di spazi dove le parole possano ricostruire il senso di sé. Dare voce alle emozioni vuol dire restituire dignità. E questo è uno dei compiti più urgenti del mondo adulto, specie per chi lavora nella scuola o accompagna la crescita in qualunque forma.
Quando si insegna a riconoscere la rabbia, la paura, il senso di ingiustizia, si dà alle persone un lessico per decodificare il mondo. Per proteggersi. Per scegliere. E sì, anche per disobbedire quando necessario. Perché la vera alfabetizzazione emotiva insegna a distinguere la colpa dalla responsabilità, il senso di vergogna dall’autenticità, l’obbedienza dalla libertà.
Non è questione di moda, ma di sopravvivenza
L’alfabetizzazione emotiva non è una moda educativa né un nuovo mantra social. È una necessità. È ciò che può fare la differenza tra un’infanzia che si racconta e un’infanzia che si spegne. Tra un’adolescenza che cerca e una che implode. È uno strumento di sopravvivenza, ma anche di fioritura.
È in grado di cambiare la traiettoria di una vita. È quello che succede quando finalmente si legittima il dolore che nessuno aveva mai riconosciuto. Quando si smette di pensare che “i bambini dimenticano”, che “gli adolescenti sono esagerati”, che “è solo una fase”.
Parole per salvarsi
L’alfabetizzazione emotiva è un atto culturale radicale, perché mette in discussione l’impalcatura su cui si regge ancora molta della nostra educazione: la repressione, la negazione, l’obbedienza. Insegnare a nominare la tristezza, la paura, l’euforia, la delusione, il senso di ingiustizia è un modo per dire: “sei legittima, sei legittimo, esisti davvero”.
Chi educa – nelle case, nelle scuole, nei servizi – ha il compito di farsi custode di queste parole, anche quando sono scomode. Perché riconoscere le emozioni è anche accettare che a volte si sbaglia, che si è impotenti, che c’è bisogno di aiuto. È accogliere l’umanità per intero, senza spingerla negli angoli bui del non detto.
Perché il silenzio non educa. Uccide.
Questo editoriale fa cultura psicologica e sociale. Ma se vivi una condizione di disagio, se senti che qualcosa non va, rivolgiti a una professionista o un professionista della salute mentale. Chiedere aiuto è il primo atto di alfabetizzazione emotiva.




